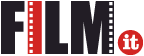NOTIZIE
L'abbazia di Chiaravalle di Fiastra
A qualche chilometro dal centro della città di Macerata nella zona della valle del Fiastra sorge l'abbazia di Chiaravalle, centro delle attività dell'ordine monastico dei Cistercensi fondato dal santo abate Bernardo di Chiaravalle nei primi anni del 1100.

07.12.2001 - Autore: Alessandro Orlandi
A qualche chilometro dal centro della città di Macerata nella zona della valle del Fiastra sorge l\'abbazia di Chiaravalle, centro delle attività dell\'ordine monastico dei Cistercensi fondato dal santo abate Bernardo di Chiaravalle nei primi anni del 1100. Da originaria microcomunità l\'ordine dei Cistercensi si diffuse rapidamente tra il XII e il XIII secolo, oltre i confini francesi in tutta Europa raccogliendo nuovi e numerosi proseliti.
Ed è proprio qui a due passi da Macerata che ancora oggi è possibile visitare la sede dell\'ordine religioso presso l\'abbazia di Chiaravalle di Fiastra.
La storia dell\'ordine è indissolubilmente legata, almeno nella prima fase di attività, alla vita del suo fondatore. San Bernardo nacque nel 1090 nel castello di Fontaines, in Francia. Fin dalla giovane età San Bernardo venne avviato alla professione religiosa. A soli venticinque anni fu inviato a Clairvaux (in lat. Clara Vallis, da cui Chiaravalle) per fondare una nuova abbazia, di cui divenne abate.
In quel territorio che oggi corrisponde alla regione delle Marche, l\'area adibita alla costruzione del complesso era stata donata allabate di Milano nella zona della valle del Fiastra.
Il luogo rispondeva alle esigenze dei monaci, che ricercavano la tranquillità e la solitudine per dedicarsi alla preghiera e alle loro mansioni quotidiane. La regione del Fiastra, per conformazione geografica, si presentava però come un territorio difficile e ostile a causa della presenza di vaste aree paludose. Grazie all\'impegno e al lavoro incessante dei monaci di Chiaravalle che eressero argini al fiume e coltivarono le terre circostanti la zona venne bonificata.
Vale davvero la pena visitare il monumento di Chiaravalle, per la mirabile bellezza architettonica della costruzione e per la solennità degli spazi.
Nel pieno rispetto della tradizione lombarda la facciata dell\'abbazia è in cotto, impreziosita da un magnifico rosone. Nel XV secolo venne aggiunto un nartece a tre campate, ovvero il tipico portico delle basiliche paleocristiane.
Una delle caratteristiche delledificio è la sua monumentale facciata: colonne e archi impreziosiscono lingresso in marmo multicolore. Il tutto è poi incorniciato da un ricercato rosone in pietra, che richiama quello che abbellisce labside. I rosoni simboleggiano la creazione delluniverso e la sua perfezione, permettendo lilluminazione delle chiese cistercensi e quindi lentrata di Dio inteso come luce e fonte di vita. La disposizione della costruzione è tale che il monaco, durante la celebrazione della Santa Messa, riceva il sole di fronte.
Particolare interesse artistico presentano i capitelli: in ognuno sono rappresentati elementi floreali e agresti. Nella navata centrale alcuni capitelli ricordano attraverso simboli e stemmi la storia dellabbazia e dellordine. Altro pezzo forte della chiesa è laltare maggiore: esso poggia su unara pagana proveniente dai resti della città romana di Urbs Salvia.
Nel braccio sinistro del transetto si apriva una porta che conduceva al cimitero dei monaci, mentre dal braccio destro si passava alla sagrestia, ed infine unaltra grande porta di pietra conduceva ai dormitori.
Uscendo dalledificio si passa nel chiostro: ha pianta quadrata e, come tradizione vuole, ha ununica apertura verso lalto per dare luce. Al centro vi era un cortile coltivato a prato e giardino, che successivamente è stato sostituito con un pavimento in mattoni. E in mezzo al cortile si trova ancora il pozzo, che consentiva ai monaci di utilizzare lacqua piovana, raccolta in una cisterna e resa, in un secondo momento, potabile.
Tra la chiesa e lingresso del chiostro vi è il cellarium, una sorta di magazzino in cui venivano riposti strumenti da lavoro e prodotti agricoli.
Il complesso abbaziale continua con la Sala del Capitolo (anche detta Sala dellascolto dello Spirito), altro luogo suggestivo e importante a cui si accedeva, attraverso un portale romanico, dal chiostro. In questa sala ascoltando la Regola dellordine, i monaci si istruivano. Sempre nella stessa sala si svolgevano tutti i riti più significativi: dalla consegna dellabito monastico ai novizi, alla sepoltura degli abati. Proprio per questo il piano della sala è di due gradini più basso rispetto a quello del chiostro: qui, simbolicamente, \"si scendeva\" per la confessione e \"si risaliva\" purificati.
Alla sinistra della sala capitolare vi è larchivio, dove si conservavano i documenti e le pergamene relativi alla storia e allattività dellabbazia. Sempre dalla sala del capitolo si accede al locutorium: il luogo dove il priore affidava le diverse mansioni ai monaci. Questa era lunica stanza in cui era permesso parlare (la Regola imponeva loro un rigoroso silenzio). Dal locutorium si giungeva direttamente ai campi, in modo da agevolare il lavoro monastico.