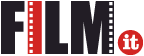Il felsineo Giorgio Diritti, reduce da un esordio (“Il vento fa il suo giro") che un paio di anni fa ha dimostrato come anche in Italia il passaparola sia ancora una leva fondamentale per aumentare gli incassi, ha svolto un'intensa ricerca storica prima di scrivere la sceneggiatura del suo “L'uomo che verrà”, basato, per l'appunto, sulla strage di Marzabotto. Il rischio di banalizzare e non rendere giustizia ad una delle pagine più strazianti della nostra vita era alto. Per evitare tutto questo Diritti costruisce le circa due ore di narrazione mostrando la vita quotidiana di una famiglia del posto. Le privazioni alimentari, le difficoltà negli spostamenti, il difficile rapporto con quei partigiani che tanto si appoggiano nei propositi quanto sono portatori di pericoli. Il climax cresce così fino alla conclusione che si conosce fin dall'inizio. Il punto di vista principale da cui seguiamo la vicenda è quella di una bambina che ha scelto di diventare muta dopo la morte prematura del fratellino e che ora aspetta impaziente che la mamma incinta partorisca nuovamente.

Lo stile di Diritti è rigoroso nel suo evitare qualsiasi enfatizzazione. Non si ricorre quasi a nessun espediente narrativo per dare ritmo o qualche snodo narrativo, ma si aspetta che il corso degli eventi storici porti la storia dentro il film. Se da una parte si tratta di una scelta apprezzabile, allo stesso tempo si rivela una decisione poco “cinematografica”, di certo poco adatta a creare empatia con lo spettatore (ma non è detto che questo fosse un obiettivo del film). Per quanto nella seconda parte del film la sua regia si riveli più fluida e ci siano alcune sequenze di buona intensità, durante i circa novanta minuti precedenti non si capisce bene quale sia lo scopo del film.

Che la tragedia ci sia stata lo si sa fin dall'inizio: creare una sorta di conto alla rovescia senza grandi contestualizzazioni storiche o politiche rende, purtroppo, “L'uomo che verrà” un ottimo documento da un punto di vista della ricostruzione (ecco spiegata quindi la scelta di far parlare gli attori in dialetto stretto), ma non un ottimo film. In finale, la domanda che ci si potrebbe porre è: perpetrare la memoria di un evento tragico è una ragione sufficiente per farne un film?